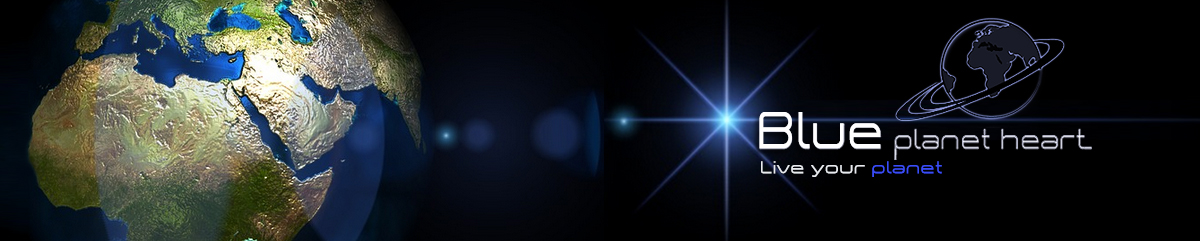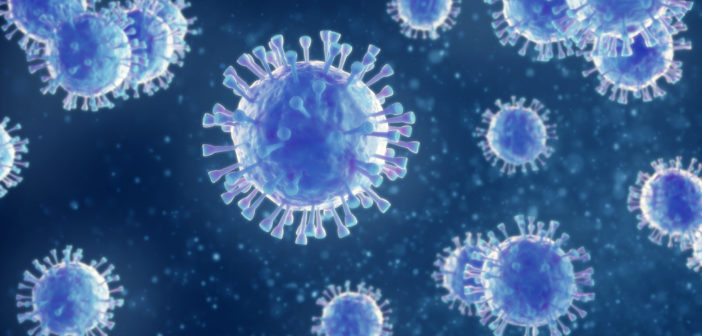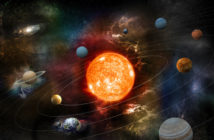Il COVID19 è mutato: i ceppi più diffusi infettano meglio le cellule e forse sono anche più contagiosi
0A causa di una mutazione riscontrata nella proteina S del coronavirus SARS-CoV-2, oggi i ceppi dominanti hanno una maggiore capacità di infettare le cellule umane e forse sono più contagiosi, ma non determinano sintomi più gravi della variante originale del patogeno. A suggerirlo i risultati di uno studio pubblicato sull’autorevole rivista scientifica Cell.
Share.