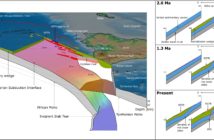Ricordando il disastro di Seveso: cosa (non) abbiamo imparato dalla Chernobyl italiana
Prima di Chernobyl e di Fukushima ci fu Seveso, anche se tanti hanno dimenticato. Ad avvelenare e seminare morte in Lombardia non fu solo la nube di diossina, ma l’omertà di chi voleva nascondere ciò che stava davvero accadendo. A quasi 50 anni dal disastro ambientale più grave della storia italiana, ci sono molte lezioni da cui avremmo dovuto apprendtere per scongiurare gli errori del passato.
Tratto da Greenme

Era il 10 luglio 1976 quando una nube tossica carica di diossina si sollevò dal reattore dell’Icmesa, un’industria chimica di Meda, in provincia di Monza e Brianza. Quella nube investì la vicina cittadina di Seveso, causando una catastrofe: bambini con lesioni cutanee, aborti, centinaia di intossicati, migliaia di animali morti, famiglie costrette ad abbandonare le loro case.
Fu uno dei peggiori disastri ambientali d’Europa. Eppure, a quasi 50 anni di distanza dall’accaduto, la domanda resta: cosa abbiamo davvero imparato da Seveso? La risposta più onesta è: molto meno di quanto avremmo dovuto.
La ricostruzione del disastro e il ruolo cruciale di Laura Conti
Tutto ebbe inizio il 10 luglio del 1976 alle 12.37, quando il sistema di controllo di un reattore chimico dell’azienda Icmesa – che produceva sostanze chimiche e farmaceutiche – andò in avaria. L’elevata temperatura innescò una pericolosa reazione che produsse TCDD, una diossina altamente tossica che venne ribattezzata “diossina Seveso”. La gigantesca nube contaminò un territorio ampio e popoloso, avvelenando persone, animali, terreni. Per le donne, le conseguenze di questo disastro furono ancora più drammatiche: la diossina, infatti, causa malformazioni fetali e mette a rischio la gestazione. In quelle ore drammatiche a perdere la vita furono oltre 3000 animali, ma nei giorni successivi ne furono abbattuti circa 76.000 per precauzione; mentre oltre 700 persone furono evacuate dalle zone più colpite. Numerosi abitanti, soprattutto bambini, svilupparono una grave malattia cutanea chiamata cloracne.
I dirigenti dell’ICMESA cercarono di minimizzare l’incidente, lasciando i lavoratori, i cittadini e i sindaci delle città brianzole più colpite come Seveso e Meda all’oscuro della gravità della situazione. Per giorni, queste persone continuarono le loro attività quotidiane – respirando aria contaminata, consumando verdure avvelenate dai loro orti – senza sapere di essere esposte a un veleno mortale. E solo il 18 luglio l’azienda ICMESA venne chiusa.
Per oltre una settimana l’incidente rimase coperto dal silenzio, finché la stampa non iniziò a occuparsene, spinta anche dall’intervento determinante di Laura Conti, considerata pioniera dell’ambientalismo italiano. Partigiana, medico, scienziata e politica, sin dai primi momenti si fece portavoce della comunità colpita dal disastro, squarciando il velo di omertà calato su Seveso e sostenendo le donne sottoposte a terrorismo psicologico a cui veniva impedito di abortire (nonostante il rischio di malformazioni a causa della diossina). Nel suo ruolo di consigliera regionale lombarda, Conti si batté strenuamente per contenere i danni del disastro, ma si trovò a fare i conti con l’inadeguatezza e la lentezza burocratica delle istituzioni pubbliche, incapaci di rispondere con la rapidità e l’efficacia richieste dalla gravità dell’emergenza e dalla pericolosità estrema della diossina.
Seveso e le lezioni che abbiamo ignorato
Dopo il terribile incidente di Seveso, l’Europa introdusse la Direttiva Seveso, con l’obiettivo di prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali pericolose. Era il tentativo di imparare dagli errori e di mettere un argine all’avidità e negligenza delle aziende. Ma il problema non era solo la mancanza di leggi: era ed è una cultura del profitto che non guarda in faccia nessuno e mette a rischio salute e ambiente. Da Seveso in poi, incidenti industriali, sversamenti e contaminazioni si sono ripetuti. Da Chernobyl a Fukushima, cambia il luogo, cambiano le sostanze, ma la dinamica resta quasi sempre la stessa: un rischio sottovalutato, un disastro evitabile, una popolazione e degli ecosistemi che ne pagano le conseguenze.
In Italia attualmente si contano 24 Siti di Interesse Nazionale (SIN) considerati gravemente contaminati, che occupano una superficie totale di 1.772 km², dove le bonifiche procedono a rilento o sono del tutto ferme. Alcuni, come quello di Seveso stesso, sono stati parzialmente riqualificati (ma la diossina è ancora presente), ma in troppi casi le bonifiche sono ostacolate da interessi politici, burocrazia e criminalità, come ad esempio nella Terra dei Fuochi, e le comunità locali spesso scoprono solo a posteriori di vivere accanto a siti pericolosi.
Abbiamo bisogno di una nuova cultura del rischio, della prevenzione, della giustizia ambientale. Non basta commemorare: serve vigilare, denunciare, educare.