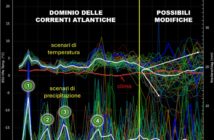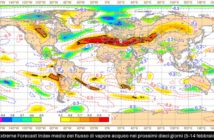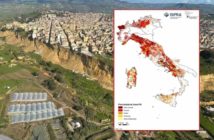Una stalagmite racconta la verità sulla fine dei Maya
Per secoli è stato uno dei grandi enigmi della storia. Ora, la chiave per comprendere la scomparsa della civiltà mesoamericana emerge dalle profondità della terra
di Riccardo Liguori
www.greenme.it
Il collasso della civiltà Maya, avvenuto tra il IX e il X secolo d.C., è uno dei grandi misteri della storia. Oggi, una nuova e straordinaria testimonianza proveniente dalla penisola dello Yucatán, in Messico, getta una luce potentissima su quegli eventi. Non si tratta di un testo antico o di un reperto archeologico, ma di una stalagmite: un archivio climatico naturale che ha registrato, anno dopo anno, la cronaca di una successione di siccità, una delle quali durata 13 anni consecutivi.
Una ricerca, condotta da un team internazionale guidato dall’Università di Cambridge e pubblicata sulla rivista Science Advances, ha analizzato una stalagmite, battezzata “Tzab06-1“, prelevata dalla grotta Grutas Tzabnah, situata a breve distanza da grandi centri Maya come Uxmal e Chichén Itzá.
La stalagmite che racconta la pioggia (e la sua assenza)
Come un albero cresce per anelli, una stalagmite si forma per strati di calcite depositati dall’acqua che gocciola dall’alto. Analizzando gli isotopi dell’ossigeno (O18) presenti in ogni singolo strato, gli scienziati sono stati in grado di ricostruire la quantità di precipitazioni cadute in un determinato periodo.
La vera svolta di questo studio, però, è la sua risoluzione temporale senza precedenti. I ricercatori sono riusciti a ottenere dati sub-annuali, distinguendo cioè tra la stagione delle piogge e quella secca per ogni singolo anno compreso tra l’871 e il 1021 d.C.. Questo dettaglio è fondamentale, perché per una civiltà agricola come quella Maya, basata sulla coltivazione del mais, non contava tanto la pioggia media annuale, quanto la sua presenza (o assenza) durante la stagione di crescita delle colture.
I risultati sono impressionanti: in un arco di 150 anni, la stalagmite ha registrato otto periodi di siccità estrema durante la stagione umida, ciascuno della durata di tre o più anni. L’evento più catastrofico fu una siccità ininterrotta che si protrasse dal 929 al 942 d.C., un periodo di 13 anni che superò per durata qualsiasi altro evento simile registrato nella storia della regione.
L’impatto sulle città Maya: risposte diverse, stesso destino
Mettendo a confronto questo calendario climatico ad alta precisione con le testimonianze archeologiche, il quadro del collasso Maya diventa molto più nitido. Le diverse città-stato non crollarono tutte insieme, ma mostrarono risposte differenti allo stress climatico.
tratto da greenme
Nella regione di Puuc, dove sorgeva la magnifica Uxmal, la civiltà dipendeva interamente da cisterne e bacini artificiali per la raccolta dell’acqua piovana. Le datazioni archeologiche mostrano che la fine della costruzione di monumenti e delle iscrizioni geroglifiche in questa area, intorno ai primi anni del 900 d.C., coincide con una serie di siccità ravvicinate registrate dalla stalagmite. La successiva, devastante siccità di 13 anni contribuì probabilmente a dare il colpo di grazia a un sistema politico e agricolo già estremamente infragilito.
Più a est, la potente Chichén Itzá mostrò una resilienza maggiore. Sebbene una sua parte più antica (“Old Chichén”) declinò in concomitanza con le prime siccità, la “New Chichén” riuscì a riprendersi e a prosperare in un periodo successivo, tra il 942 e il 1022 d.C., caratterizzato da siccità meno frequenti e da diversi periodi umidi. La sua forza risiedeva probabilmente in un sistema politico-economico differente, basato su una vasta rete di tributi e commercio che poteva mitigare gli effetti di un cattivo raccolto locale.
Tuttavia, neanche la potente Chichén Itzá fu invincibile. Il suo declino finale avvenne all’inizio dell’XI secolo, in coincidenza con una “megadrought” (mega-siccità) post-classica che segnò la fine di un’era.