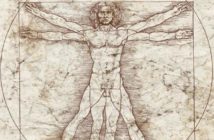Conoscere meglio le correnti piroclastiche dell’Etna
di Boris Behncke, Daniele Andronico, Stefano Branca, Annalisa Cappello, Francesco Ciancitto, Paola del Carlo, Mattia de’ Michieli Vitturi, Alessio Di Roberto, Gaetana Ganci, Tomaso Esposti Ongaro e Francesco Zuccarello
tratto da INGVVULCANI

di Boris Behncke, Daniele Andronico, Stefano Branca, Annalisa Cappello, Francesco Ciancitto, Paola del Carlo, Mattia de’ Michieli Vitturi, Alessio Di Roberto, Gaetana Ganci, Tomaso Esposti Ongaro e Francesco Zuccarello
Turisti in fuga da un vulcano in eruzione, mentre una nube scura e si propaga lungo i suoi fianchi. Il 2 giugno 2025 le immagini hanno fatto il giro del mondo: una corrente piroclastica. E’ il fenomeno più pericoloso e letale che un vulcano possa produrre. Ma non si tratta di un vulcano in un paese lontano ed esotico, bensì dell’Etna.
Se in passato l’Etna è stato considerato un vulcano dal carattere piuttosto mite, “gentile”, principalmente effusivo ma non esplosivo, negli ultimi 25 anni il suo “carattere” è molto cambiato, diventando talvolta fortemente esplosivo. Le correnti piroclastiche, più comunemente conosciute come flussi piroclastici o nubi ardenti, sono tra i fenomeni distintivi delle eruzioni vulcaniche più esplosive. Si tratta di valanghe di gas, ceneri, lapilli e blocchi di materiale roccioso frammentato ad alte temperature (diverse centinaia di gradi), che si muovono a velocità elevate (centinaia di chilometri all’ora). Fino alla fine del XX secolo, quasi nessuno avrebbe associato anche all’Etna questo fenomeno, essendo invece considerato caratteristico di vulcani più esplosivi come il Vesuvio o i vulcani del Giappone, dell’Indonesia, o del Sud America.
Sui fianchi dell’Etna affiorano enormi depositi di correnti piroclastiche, prodotti circa 15 mila anni fa durante una fase di attività esplosiva molto violenta , mentre flussi più contenuti si sono formati durante l’eruzione pliniana del 122 a.C.
Tuttavia, dal 1986, si sono osservate circa trenta correnti piroclastiche sull’Etna, che negli ultimi anni sono diventate sempre più frequenti. L’evento più recente, spettacolare ma anche spaventoso per la presenza di molte persone nelle aree interessate, si è verificato durante un episodio parossistico il 2 giugno 2025. Si tratta presumibilmente del flusso più voluminoso ed esteso tra quelli documentati dal 1986, avendo percorso circa 3 km in direzione della Valle del Bove. Certamente è stato anche quello più “mediatico”, grazie alla coincidenza con un giorno festivo e in condizioni di eccezionale visibilità, che ha permesso a migliaia di osservatori – sia sul posto che a distanza – di registrare immagini e video.
Una breve cronologia
Degli oltre trenta eventi che hanno generato valanghe piroclastiche, uno è avvenuto al Cratere di Nord-Est il 24 settembre 1986 e l’altro il 25 ottobre 1999 al cratere Bocca Nuova, il più grande dei crateri sommitali. Altri due eventi di minore entità sono stati registrati dai crateri Bocca Nuova nel 2013 e Voragine nel 2024. Ma la maggior parte delle correnti piroclastiche sono da mettere in relazione all’attività eruttiva del Cratere di Sud-Est, il più giovane e attivo dei crateri sommitali.
Spiccano tra questi episodi quelli del 16 novembre 2006, dell’11 febbraio 2014 e del 10 febbraio 2022, avvenuti in circostanze diverse: i primi due, durante fasi di attività stromboliana (rispettivamente intensa e moderata) accompagnata da emissione di colate laviche; il terzo, al culmine di un episodio parossistico molto violento. In tutti gli episodi, le correnti piroclastiche sono state causate dalla instabilità dei fianchi del Cratere di Sud-Est, resi fragili dalle fratture generate dalle attività precedenti e ulteriormente indeboliti dall’apertura di nuove fratture eruttive, che hanno portato al collasso. Già a febbraio 2020, in un Bollettino Settimanale sull’attività dell’Etna era stata notata la potenziale instabilità di un settore del cono, che effettivamente crollò la sera del 13 dicembre del 2020.
La corrente piroclastica del 10 febbraio 2022
Dopo alcuni mesi di relativa calma e alcuni giorni di minore attività esplosiva, il Cratere di Sud-Est ha prodotto un intenso episodio parossistico nella serata del 10 febbraio 2022. Durante le prime ore, l’attività si manifestava con esplosioni stromboliane ed emissione di una colata di lava verso sud-ovest, seguendo la tipica coreografia degli episodi eruttivi iniziati un anno prima. Nell’intervallo tra le 20:30 e le 21:15, l’attività è gradualmente passata da stromboliana a fontane di lava (Figura 1).

I primi piccoli flussi piroclastici si sono formati a partire dalle ore 21:34 (locali) a causa dell’abbondante ricaduta di materiale piroclastico incandescente sul ripido fianco del cono, seguiti da altri, che hanno avvolto l’intero settore meridionale e sud-orientale del Cratere di Sud-Est. Al culmine dell’attività, intorno alle ore 22:20, una fessura eruttiva ha tagliato il versante meridionale del cono, producendo fontane di lava e una nuova colata lavica diretta verso sud. Questa fratturazione del fianco del cono ha portato alla sua destabilizzazione, risultando nel collasso di una parte del versante, coinvolgendo sia frammenti del cono (materiale accumulato durante le attività precedenti), sia lava incandescente. Da questo collasso si è formata una corrente piroclastica, che ha percorso 1.4 km in poco meno di un minuto, superando un cospicuo ostacolo morfologico: il più alto dei due coni costruiti durante l’eruzione del 2002-2003 a circa 1 km dal Cratere di Sud-Est. Le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e dai testimoni mostrano che il flusso era incandescente; inoltre, quando si è sollevata la nube di gas e cenere, è apparso evidente che anche il deposito risultava incandescente. Le alte temperature hanno incendiato una capanna protettiva parzialmente costruita in legno e carbonizzato oggetti in legno anche nelle zone dove il deposito era molto sottile.
In quel momento l’attività esplosiva stava producendo fontane di lava alte oltre un chilometro e una colonna eruttiva alta fino a 12 km sopra il livello del mare, all’interno della quale erano visibili numerosi fulmini. Dalle ore 22:45 in poi, l’attività è diminuita e si è conclusa verso le 23:00.
Il Cratere di Sud-Est e il deposito della corrente piroclastica dopo il parossismo
Il giorno seguente, il Cratere di Sud-Est si presentava con un’ampia depressione profonda diverse decine di metri nel suo fianco meridionale, mettendo a nudo la sua stratigrafia interna. Per diverse settimane, dalle pareti instabili della nicchia di collasso sono avvenute piccole frane, esponendo materiale ancora caldo. Il 21 febbraio 2022 una nuova colata di lava prodotta da un ulteriore episodio parossistico ha percorso la stessa depressione, sovrapponendosi parzialmente alla lava del 10 febbraio (Figura 2).

Il graduale riempimento della profonda depressione prodotta dal collasso del fianco del Cratere di Sud-Est è proseguito grazie ai prodotti effusivi ed esplosivi emessi durante quattro episodi parossistici dello stesso Cratere di Sud-Est nel 2023, ma anche per effetto degli abbondanti depositi di caduta generati da sei episodi parossistici dal cratere Voragine nel corso del 2024.
Diversamente da altri flussi piroclastici che in precedenza avevano interessato i fianchi sommitali dell’Etna — spesso rapidamente ricoperti da prodotti di attività successive o localizzati in zone di difficile accesso — il deposito del 10 febbraio 2022 è rimasto praticamente intatto per più di un anno (Figura 3). Questo ha reso possibile un’estesa campagna di mappatura e campionamento, seguita da approfondite analisi di laboratorio.

Cause del collasso e dinamica di propagazione della corrente piroclastica
Nello studio appena pubblicato sulla rivista Nature Communications Earth & Environment, intitolato “Trigger mechanism and propagation dynamics of pyroclastic density currents in basaltic volcanoes”, condotto da ricercatori INGV delle Sezioni di Catania e di Pisa, sono state indagate le condizioni e le dinamiche che hanno portato all’innesco della valanga piroclastica del 10 febbraio 2022. In particolare, attraverso un approccio multidisciplinare, sono stati combinati e integrati tra loro dati di campagna (Figura 4), di laboratorio (attraverso analisi granulometriche e tessiturali sui prodotti campionati dal deposito), e immagini satellitari (Figura 5).


Le osservazioni sono state infine supportate da un modello numerico per la simulazione fisica dei flussi per studiarne meglio le dinamiche di propagazione. I risultati suggeriscono che il materiale piroclastico che costituiva il fianco sud del Cratere di Sud-Est prima del collasso si è accumulato velocemente durante le attività eruttive del 2021 (Figura 6).

L’elevata pendenza raggiunta dal fianco, insieme alle alte temperature residue (> 700 °C) e all’alterazione idrotermale che tipicamente interessa i depositi superficiali, ha favorito l’instabilità strutturale dell’area, predisponendola al collasso avvenuto durante l’eruzione del 10 febbraio 2022. L’apertura della frattura ha agito come fattore scatenante provocando la destabilizzazione totale del fianco del cono.
Dalla modellazione numerica è emerso che la valanga si è propagata con una velocità iniziale molto alta, non attribuibile… L’ARTICOLO CONTINUA QUI