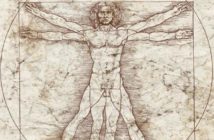Dove c’era il terzo lago d’Italia, ora c’è un mosaico di agricoltura intensiva: l’immagine dai satelliti è impressionante
L’immagine satellitare della Piana del Fucino rivela un paesaggio geometrico. Non è un errore, ma il risultato di una colossale opera di ingegneria che ha cancellato un lago per fare spazio all’agricoltura intensiva. E in questa terra fertile ora sorge uno dei più importanti centri spaziali
www.greenme.it
A guardarla dallo spazio, come nell’immagine catturata da uno dei satelliti Copernicus Sentinel-2, la Piana del Fucino, in Abruzzo, appare come uno schermo a bassa risoluzione, un’opera d’arte digitale composta da migliaia di pixel colorati. Ma non è un’immagine sgranata: è la fotografia di una delle trasformazioni ambientali e umane più radicali della storia d’Italia

@Unione Europea, immagini Copernicus Sentinel-2
Dove oggi si estende un ordinato mosaico di campi rettangolari per 160 km², un tempo si trovava il terzo lago più grande della penisola, dopo il Garda e il Maggiore.
La storia del lago del Fucino
La storia di questo luogo è la storia di una lotta secolare tra l’uomo e l’acqua. Il lago Fucino, di origine tettonica e privo di un emissario naturale, era soggetto a imprevedibili e drastiche variazioni di livello.
Le sue piene inondavano i campi, mentre i periodi di secca lasciavano paludi malsane, focolai di malaria. Già i Romani, che pure apprezzavano l’area per il clima secco e le villeggiature, tentarono l’impresa. L’imperatore Claudio, tra il 41 e il 52 d.C., mobilitò 30.000 uomini per scavare un emissario sotterraneo di oltre 5,6 chilometri sotto il monte Salviano, un’opera ingegneristica colossale per drenare le acque nel fiume Liri. L’esito fu solo un parziale e temporaneo successo: con la caduta dell’Impero Romano, la manutenzione venne meno e il lago si riprese lentamente i suoi spazi.
L’impresa di Torlonia e le sue conseguenze
Il capitolo decisivo fu scritto nella seconda metà dell’Ottocento dal banchiere Alessandro Torlonia. Riprendendo e ampliando il progetto romano, investì un capitale enorme e impiegò migliaia di operai in un’impresa che sembrava impossibile, tanto da fargli pronunciare la celebre frase: “O Torlonia asciuga il Fucino, o il Fucino asciuga Torlonia”. I lavori, durati dal 1854 al 1878, portarono al prosciugamento totale del bacino. Il fondo del lago si rivelò un terreno straordinariamente fertile, ma la sua conquista ebbe costi sociali altissimi.
La terra bonificata divenne quasi interamente proprietà dei Torlonia, trasformando le comunità di pescatori in un esercito di braccianti agricoli. La condizione di questi contadini, i “cafoni”, fu descritta da Ignazio Silone nel suo romanzo Fontamara: «In capo a tutti c’è Dio, padrone del cielo. Questo ognuno lo sa. Poi viene il principe Torlonia, padrone della terra. Poi vengono le guardie del principe. Poi vengono i cani delle guardie del principe. Poi, nulla. Poi, ancora nulla. Poi, ancora nulla. Poi vengono i cafoni. E si può dire ch’è finito». Le dure lotte contadine del secondo dopoguerra, culminate nell’eccidio di Celano del 1950, portarono alla Riforma Agraria che espropriò i terreni e li redistribuì ai coltivatori.
Dall’orto d’Italia allo Spazio
Oggi, la Piana del Fucino è uno degli “orti” più produttivi d’Italia, celebre per le sue coltivazioni di ortaggi e tuberi, tra cui la Patata del Fucino IGP e la Carota dell’Altopiano del Fucino IGP. Il prosciugamento ha però alterato profondamente anche il microclima locale.
Senza la grande massa d’acqua a mitigare le temperature, l’area è ora soggetta a forti escursioni termiche, con inverni più rigidi e gelate intense, ed estati più secche. In questa terra di contrasti, accanto alle antiche tradizioni agricole, sorge un simbolo della modernità più spinta: il Centro Spaziale del Fucino “Piero Fanti” di Telespazio, uno dei più grandi teleporti al mondo per le telecomunicazioni satellitari.
Fonte: Copernicus Sentinel-2