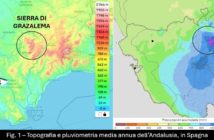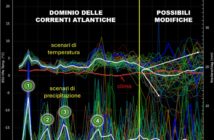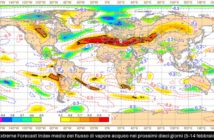Hawking e Kerr avevano ragione: confermate due ipotesi fondamentali sui buchi neri, grazie alle onde gravitazionali
Un segnale prodotto da una collisione tra due buchi neri ha permesso di verificare due previsioni teoriche fondamentali su questi oggetti celesti bizzarri e misteriosi, a dieci anni esatti dalla prima rilevazione diretta di onde gravitazionali
di Matteo Serra
www.lescienze.it

Esattamente dieci anni fa, il 14 settembre 2015, l’esperimento statunitense LIGO osservò per la prima volta un segnale di onde gravitazionali, prodotto dalla fusione di due buchi neri. A distanza di quasi un decennio, nel gennaio 2025, la collaborazione scientifica LIGO-Virgo-KAGRA (LVK) ha rilevato un segnale gravitazionale straordinariamente “pulito”, generato da un evento molto simile a quello del 2015.
Grazie a una tecnologia di rilevazione più avanzata e a metodi di analisi più raffinati rispetto a quelli disponibili dieci anni fa, lo studio di questo evento ha permesso di verificare due previsioni teoriche fondamentali sui buchi neri: il teorema dell’area di Stephen Hawking – secondo cui la superficie dell’orizzonte degli eventi di un buco nero non può mai diminuire nel tempo – e la cosiddetta “soluzione di Kerr”, conseguenza della teoria generale della relatività di Albert Einstein, per cui un buco nero astrofisico può essere descritto da due soli parametri, la massa e il momento angolare. I risultati sono stati pubblicati sulle “Physical Review Letters”.

I buchi neri sono considerati da sempre tra gli oggetti più bizzarri e misteriosi del cosmo. La loro caratteristica chiave è la presenza di un punto di non ritorno: una volta superato un confine ben preciso detto “orizzonte degli eventi”, il campo gravitazionale dei buchi neri diventa così intenso da impedire sia alla materia sia alla luce di sfuggire. Se in origine i buchi neri erano semplici soluzioni matematiche della relatività generale di Einstein, oggi esistono prove solide della loro reale esistenza astrofisica: in particolare, un buco nero può costituire lo stadio finale dell’evoluzione di una stella molto massiccia.
Gli eventi di coalescenza, in cui coppie di buchi neri collidono fino a fondersi tra loro, dando luogo a un unico buco nero finale più massiccio, costituiscono un modo per “osservare” indirettamente questi affascinanti oggetti celesti: questi eventi producono infatti una grande quantità di onde gravitazionali, debolissime increspature dello spazio-tempo che, una volta generate, si propagano indisturbate nell’universo, portando con sé informazioni preziose sui fenomeni che le hanno generate.
Dal 2015, anno della prima rilevazione, la rete di osservatori gravitazionali terrestri – che comprende i due interferometri LIGO negli Stati Uniti (a Hanford e Livingston), Virgo in Italia (a Cascina, vicino Pisa) e KAGRA in Giappone – ha registrato oltre 200 segnali di onde gravitazionali, quasi tutti generati proprio da fusioni tra buchi neri.

Ma in che modo è possibile riconoscere le caratteristiche di un buco nero (come per esempio la sua massa o velocità di rotazione) dall’analisi delle onde gravitazionali emesse in questi eventi estremi?
“Pensiamo a un bicchiere di vetro: se viene colpito, produce un suono le cui frequenze rivelano la forma e il materiale di cui è composto. Analogamente, quando un buco nero viene perturbato, esso vibra con delle frequenze caratteristiche, da cui è possibile ricavare informazioni sulla sua struttura. Analizzando i segnali di onde gravitazionali, è possibile estrarre queste frequenze”, ci spiega Gregorio Carullo, docente all’Università di Birmingham, nel Regno Unito, membro della collaborazione LVK e coordinatore di uno dei gruppi di analisi dati responsabili della misura di queste frequenze.
Tra i numerosi segnali registrati dalla collaborazione nell’attuale ciclo di presa dati (O4), uno in particolare ha destato fin da subito attenzione: l’evento chiamato GW250114, rilevato il 14 gennaio 2025 dai due strumenti di LIGO. Il segnale di onde gravitazionali associato a questo evento – generato dalla coalescenza tra due buchi neri, che ha dato origine a un buco nero finale di circa 63 masse solari – è il più nitido tra quelli osservati finora (a testimoniarlo è un valore insolitamente elevato, rispetto allo standard, del rapporto segnale-rumore). Ciò ha permesso ai ricercatori di poter “seguire” in modo preciso l’intera collisione, dall’istante in cui i due buchi neri hanno iniziato a fondersi fino alle ultime vibrazioni del buco nero risultante, che si è stabilizzato nel suo nuovo stato in un tempo di circa dieci millisecondi.
“Questo intervallo di tempo può sembrare molto piccolo, ma gli strumenti di analisi che abbiamo oggi a disposizione sono così avanzati da renderlo più che sufficiente a studiare in dettaglio le vibrazioni del buco nero finale”, sottolinea Maximiliano Isi, docente alla statunitense Columbia University e leader di un altro gruppo di analisi dati della collaborazione LVK, che in questo studio ha lavorato parallelamente a quello guidato da Carullo.
L’osservazione dettagliata di GW250114 ha permesso alla collaborazione di mettere alla prova la soluzione della relatività generale di Einstein ottenuta dal fisico neozelandese Roy Kerr nel 1963, che descrive buchi neri rotanti. “La soluzione di Kerr è fondamentale nell’ambito della relatività generale. Essa implica che un buco nero è completamente caratterizzato da due soli parametri: la sua massa e il suo momento angolare. La conseguenza è che questa soluzione descrive tutti i buchi neri rotanti dell’universo”, evidenzia Carullo.

Grazie all’incredibile nitidezza del segnale osservato – e ai software sviluppati dai gruppi di analisi dati – è stato possibile ottenere una verifica accurata della soluzione di Kerr, mai raggiunta in precedenza. “Per la prima volta siamo riusciti a misurare sia il modo vibrazionale fondamentale, sia la ‘prima armonica’ del buco nero finale, permettendoci di verificare con grande precisione la previsione di Kerr”, aggiunge il ricercatore italiano. Il software di analisi “pyRing”, usato dal gruppo di Carullo, è stato sviluppato durante il suo dottorato all’Università di Pisa, sotto la supervisione di Walter Del Pozzo (docente nella stessa università), mentre l’analisi di questo evento è stata condotta da Giada Caneva Santoro e Vasco Gennari, membri della collaborazione Virgo.
Il buco nero di GW250114, insomma, risulta effettivamente descritto da due soli parametri, la massa e il momento angolare. Ma non è tutto. L’osservazione di questo evento ha permesso di verificare anche un altro caposaldo della teoria dei buchi neri: il teorema dell’area di Hawking, secondo cui la superficie dell’orizzonte degli eventi di un buco nero non può mai diminuire. Formulata da Stephen Hawking nel 1971, l’ipotesi porta in dote un sorprendente parallelo con il secondo principio della termodinamica. Quest’ultimo prevede infatti che l’entropia, una grandezza fisica che rappresenta il grado di disordine di un sistema fisico, non possa mai decrescere nel tempo. La conseguenza è che i buchi neri possono essere descritti come oggetti termici ed emettere radiazione, sia pure su una scala temporale estremamente lunga: questo fenomeno è noto come “radiazione di Hawking” e rappresenta una delle proprietà più iconiche dei buchi neri.
Per mettere alla prova il teorema, è necessario misurare l’area totale degli orizzonti degli eventi dei buchi neri iniziali e quella dell’orizzonte del buco nero finale, verificando che quest’ultima risulti maggiore. Tale misurazione è possibile proprio grazie alla soluzione di Kerr, una volta estratti dal segnale gravitazionale i valori della massa e del momento angolare dei buchi neri. Nel 2021, uno studio guidato da Maximiliano Isi – basato sul primo segnale di onde gravitazionali osservato nel 2015 e su un modello più speculativo – aveva fornito una prima conferma del teorema dell’area di Hawking, tuttavia una parte della comunità scientifica non l’aveva considerata sufficientemente solida. Con l’evento GW250114, invece, la limpidezza del segnale e gli strumenti di analisi usati hanno permesso una verifica molto più accurata, accolta all’unanimità dalla collaborazione scientifica.
Gli obiettivi degli scienziati di LVK non si esauriscono qui. I numerosi eventi già registrati in O4, insieme a quelli che arriveranno nel prossimo ciclo di presa dati (quando i rivelatori avranno una sensibilità ancora maggiore) promettono di aprire la strada non solo a nuove verifiche della teoria di Einstein, ma anche a possibili scoperte inaspettate.