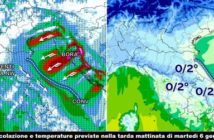Il Sistema di Monitoraggio multiparametrico dell’INGV-Osservatorio Vesuviano sui vulcani campani
di Fabio Sansivero, Mario Castellano, Lucia Pappalardo
tratto da INGVTERREMOTI
Il monitoraggio multiparametrico terrestre e marino delle aree vulcaniche napoletane (Campi Flegrei, Vesuvio e Ischia) operato dall’INGV-Osservatorio Vesuviano (INGV-OV) è effettuato utilizzando reti di monitoraggio progettate per analizzare e comprendere i fenomeni geofisici, geochimici e vulcanici generati dalla dinamica in corso su ciascun sistema vulcanico (Figura 1).

Le acquisizioni in tempo reale o a cadenza regolare di tali reti sono integrate da campagne di misura periodiche ed analisi in situ e in laboratorio. I dati così ottenuti sono elaborati dall’INGV-OV per individuare e interpretare anche le più piccole variazioni nei fenomeni osservati, integrandoli con le conoscenze già disponibili e con la storia eruttiva del vulcano monitorato. Le reti di monitoraggio sono costantemente migliorate aumentando la densità spaziale dei sistemi di rilevazione, ma anche aggiornando l’infrastruttura in coerenza con i più recenti sviluppi tecnologici.
In particolare, per i Campi Flegrei, a seguito del passaggio al Livello di Allerta GIALLO, è in atto un continuo potenziamento del Sistema di Monitoraggio che consente di rilevare con incertezze sempre minori le variazioni dei parametri monitorati.
Sebbene sia data priorità all’interpretazione dei dati in tempo reale, vengono dedicate significative risorse alla risoluzione dei problemi legati all’analisi dei dati, alla promozione di ricerche finalizzate a una migliore comprensione dello stato dei vulcani e allo sviluppo di strumenti di monitoraggio più avanzati.
Gli obiettivi del Sistema di Monitoraggio
Il monitoraggio vulcanico si fonda su un approccio intrinsecamente multidisciplinare, in cui i dati della singola Rete di Monitoraggio costituiscono una componente fondamentale ma non esaustiva. L’integrazione dei dati registrati da tutte le Reti consente di ottenere una visione più completa dei processi in atto, migliorando la capacità di discriminare tra segnali precursori effettivi e variazioni transitorie non correlate a significativi cambiamenti della dinamica vulcanica. L’analisi congiunta di dati multidisciplinari rappresenta quindi un elemento imprescindibile per affinare i modelli interpretativi e supportare in modo più efficace le strategie di mitigazione del rischio vulcanico.
Monitoraggio Sismologico
La Rete di Monitoraggio Sismologico consente di rilevare i segnali sismici generati da processi di fratturazione e da processi legati a movimenti di fluidi magmatici e/o magma (eventi LP, VLP, tremore), localizzarli e definire la magnitudo.
La Rete Sismica terrestre e marina è attualmente così composta:
- Campi Flegrei: 27 stazioni permanenti terrestri e marine (queste ultime relative all’infrastruttura MEDUSA) di cui 13 dotate anche di accelerometro + 7 stazioni della Rete Mobile in trasmissione di cui 5 dotate anche di accelerometro e una di sensore infrasonico
- Vesuvio: 18 stazioni permanenti di cui 6 dotate anche di accelerometro + 6 stazioni della Rete Mobile in trasmissione di cui 2 dotate di accelerometro
- Ischia: 8 stazioni permanenti di cui 5 dotate anche di accelerometro + 3 stazioni della Rete Mobile in trasmissione di cui 1 dotata anche di accelerometro
In alcuni siti di particolare importanza, i sistemi di acquisizione e di trasmissione, nonché i sensori sismici, sono ridondati per garantire la continuità dei dati anche in caso di eventuali problemi tecnici.
Sebbene la Rete operi in un’area altamente urbanizzata e in prossimità del mare, con sensibile rumore di fondo di origine antropica e meteomarina, l’ottimizzazione della strumentazione e delle tecniche di installazione dei siti consente un’elevata capacità di detezione garantendo un’alta qualità delle analisi dei dati sismologici (Figura 2).
A titolo di esempio, per i Campi Flegrei, grazie alla densità delle stazioni e all’elevata sensibilità della strumentazione, la Magnitudo di completezza del catalogo sismico (soglia di magnitudo al di sotto della quale non viene garantita la rilevazione di tutti i terremoti avvenuti) è di MD = 0.2, con una magnitudo minima rilevata pari a MD = -1.6.
La Magnitudo utilizzata per i terremoti dei vulcani campani è la Magnitudo Durata (MD), per gli eventi di maggiore energia vengono calcolate anche la Magnitudo Locale (ML) e la Magnitudo Momento (MW).

Monitoraggio Geodetico
Rete GNSS
La Rete GNSS (Global Navigation Satellite System) monitora l’andamento delle deformazioni del suolo, parametro chiave per la sorveglianza vulcanica. La misura continua degli spostamenti tridimensionali, con precisione millimetrica, consente di rilevare variazioni indotte da pressurizzazione del sistema magmatico, intrusioni magmatiche, fratturazione crostale e processi idrotermali su ampia scala.
La Rete GNSS è attualmente così composta:
- Campi Flegrei: 40 stazioni terrestri e marine (infrastruttura MEDUSA)
- Vesuvio: 14 stazioni
- Ischia: 7 stazioni più 1 stazione installata a Procida
Le stazioni sono equipaggiate con ricevitori GNSS (Figura 3) di ultima generazione (Leica GR10 e GR50) e antenne Choke Ring (Leica AR20 e AR25). La configurazione prevede una doppia acquisizione locale (file giornaliero a 30s e orario a 1s) e la trasmissione in tempo reale a 1Hz verso la Sala di Monitoraggio INGV-OV dove è operativo un sistema dedicato al processamento e alla visualizzazione dei dati.
La gestione remota delle stazioni e il download dei dati avviene in tempo reale. Anche l’analisi viene effettuata in tempo reale tramite più software di processamento dati GNSS nell’ottica della ridondanza dei sistemi di elaborazione dati con modalità differenti al fine di escludere o meglio definire possibili errori dei segnali registrati. Procedure automatiche giornaliere curano la validazione, l’archiviazione e l’elaborazione dei dati GNSS, restituendo serie temporali delle variazioni (componenti Nord, Est e Quota), campi di velocità e spostamenti planimetrici e verticali.

Rete Tiltmetrica
La Rete Tiltmetrica acquisisce in continuo la componente angolare della deformazione del suolo e ha come obiettivo principale la caratterizzazione della cinematica e l’evoluzione della deformazione crostale associata all’attività dei vulcani. Differentemente dalla Rete GNSS, i tiltmetri rilevano anche deformazioni molto piccole (fino ai nanoradianti), utili per evidenziare fenomeni localizzati (Figura 4).
La Rete Tiltmetrica è attualmente così composta:
- Campi Flegrei: 12 stazioni (4 con sensori analogici di superficie, 3 con sensori analogici in pozzi da 1 a 10 metri e 5 digitali in pozzi di 25 metri). In fase di completamento l’installazione di un’ulteriore stazione digitale in pozzo di 25 metri.
- Vesuvio: 7 stazioni (3 con sensori analogici di superficie e 4 con sensori digitali in pozzi di 25 metri). In fase di completamento l’installazione di altre 3 stazioni con sensori digitali in pozzi di 25 metri.
- Ischia: 5 stazioni con sensori digitali in pozzi da 25 metri.
La rete tiltmetrica è composta da sensori elettronici biassiali con trasduttore a bolla che misurano le variazioni di inclinazione del suolo lungo direzioni ortogonali X e Y (una per ciascun asse di inclinazione). La tipologia dei sensori utilizzati è legata alle caratteristiche dei siti:
– sensori analogici borehole Applied Geomechanics (mod. 722) con risoluzione di 0.1 radianti per installazioni in pozzi poco profondi (tra 1 e 10 metri);
– sensori di superficie Jewell Instruments mod. A603 ad alta risoluzione (<25 nanoradianti), posizionati in gallerie e in pozzetti poco profondi;
– sensori digitali borehole Jewell Instruments mod. Lily, con risoluzione di 0.005 radianti, forniti anche di bussola magnetica e sistema di auto-livellamento, installati in pozzi profondi 25 metri.

Rete Mareografica
La Rete Mareografica misura i movimenti relativi tra il suolo e il livello marino e i fenomeni idrodinamici rapidi nei siti di installazione costieri, fornendo un contributo alla comprensione dei processi vulcano-tettonici e per la mitigazione del rischio costiero e tsunamigenico.
La Rete Mareografica è attualmente così composta:
- Campi Flegrei: 5 stazioni
- Vesuvio: 3 stazioni
- Ischia: 1 stazione in corso di completamento
Le stazioni mareografiche misurano il livello mareometrico mediante sensori elettro-meccanici (Figura 5). I segnali, campionati ogni minuto, sono acquisiti da un convertitore A/D, memorizzati in file locali e trasmessi alla Sala di Monitoraggio dell’INGV-OV.
Le stazioni sono installate sulle banchine dei relativi moli e soggette a costante manutenzione effettuata da personale subacqueo specializzato. La stazione mareografica CFB3 della relativa boa dell’infrastruttura marina multiparametrica MEDUSA nel Golfo di Pozzuoli e la stazione POPT (Pozzuoli Porto) sono provviste di un sensore digitale di tipo radar con frequenza di campionamento di un campione al minuto.

Rete Dilatometrica
La Rete Dilatometrica installata ai Campi Flegrei misura le microdeformazioni volumetriche del campo di strain locale (Figura 6). Tale rete permette di individuare sorgenti di deformazione in profondità con una sensibilità molto superiore (anche di diversi ordini di grandezza) rispetto alle misure di spostamento.
La Rete Dilatometrica è attualmente così composta:
- Campi Flegrei: 4 stazioni di cui 2 operative e due in corso di ripristino
Le stazioni sono equipaggiate con dilatometri Sacks-Evertson con acquisizione tramite un sistema combinato SOC-box + acquisitore multicanale Affinity o datalogger SHOE-box.
I dilatometri hanno precisioni nominali dell’ordine di 10-12, rispetto ad ampi intervalli di frequenze (da 10-7 fino a 102 Hz), e sono caratterizzati da un’elevata dinamica (140 dB). Tali strumenti sono installati in pozzi di profondità compresa tra 120 e 180 m per minimizzare l’effetto sui segnali acquisiti delle variazioni termiche in superficie e delle attività antropiche.

Rete Gravimetrica
La Rete Gravimetrica consente misure di gravità terrestre alle diverse stazioni permettendo di rilevare e quantificare variazioni temporali e spaziali del campo gravitazionale legate a diverse possibili cause, quali movimenti di masse magmatiche, oppure variazioni di densità e di pressione nel sistema idrotermale o a deformazioni crostali.
La Rete Gravimetrica è attualmente così composta:
- Campi Flegrei: 1 stazione permanente per misure relative in continuo, circa 40 punti di misura per campagne di acquisizione periodica
- Vesuvio: circa 35 punti di misura per campagne di acquisizione periodica
- Ischia: circa 25 punti di misura per campagne di acquisizione periodica
A partire da gennaio 2023 sono in corso misure gravimetriche in continuo con un gravimetro gPhoneX (risoluzione di 0.1 μGal [microGal] e precisione di 1 μGal) installato nei Campi Flegrei presso l’Oasi Naturale WWF di Astroni (Figura 7). I dati “raw” acquisiti vengono processati per rimuovere i contributi gravimetrici legati alle maree, agli effetti di tilt, ai fenomeni atmosferici, ai terremoti e alla deriva strumentale.
Periodicamente vengono effettuate campagne di misure di gravimetria relativa sui singoli vulcani campani, con una frequenza che è funzione dello stato di attività. Tali misure sono eseguite sia con un classico gravimetro LaCoste & Romberg modello D che con un gravimetro di ultima generazione Scintrex-CG6-574 e corrette per gli effetti di variazione della marea solida, del carico atmosferico e della deriva strumentale.
La successiva compensazione degli errori di chiusura viene eseguita su circuiti concatenati dell’intera rete, ottenendo errori medi sulle reti inferiori a ±10 μGal (1 μGal = 10-8m/s2, equivalente a 10-9g).

Monitoraggio Vulcanologico
Le attività di monitoraggio vulcanologico vengono svolte dall’INGV-OV mediante una Rete permanente di telecamere all’infrarosso termico (TIRNet) e attraverso campagne di misure periodiche con telecamera all’infrarosso termico portatile, termocoppia e drone.
Rete Permanente di Monitoraggio Termico ad Immagine
L’acquisizione quotidiana notturna di immagini all’infrarosso termico, eseguita dalla Rete TIRNet su aree soggette ad anomalia termica, consente di monitorare le variazioni del campo di temperatura superficiale di aree a degassamento diffuso (fumarole). Tali variazioni sono generalmente connesse ai processi di degassamento profondo e alla loro interazione con il sistema idrotermale, e forniscono elementi utili per la valutazione dello stato di attività del vulcano.
La Rete Permanente di Monitoraggio Termico ad Immagine (TIRNet) è attualmente così composta:
- Campi Flegrei: 6 stazioni
- Vesuvio: 1 stazione
Tutte le stazioni sono attualmente equipaggiate con termocamere FLIR SC645/655 che acquisiscono immagini con risoluzione 640×480 nella banda dell’infrarosso termico (7.5-13 μm). L’accuratezza del sensore è ± 2°C e la sensibilità termica è di 30 mK (a 50/60 Hz). La stazione di acquisizione remota, ideata e sviluppata dal TIRLab INGV-OV, gestisce l’acquisizione automatica giornaliera delle immagini IR e il trasferimento dei dati ai server della Sala di Monitoraggio INGV-OV dove sono riportati i grafici delle temperature aggiornati giornalmente (Figura 8). L’elaborazione automatizzata prevede riallineamento dell’immagine all’infrarosso, analisi statistica e destagionalizzazione delle serie temporali di temperature e di flusso di calore radiativo, tramite applicativo Matlab sviluppato dal TIRLab INGV-OV.

Rete di Monitoraggio Termico con termocamera portatile, termocoppia e drone
La Rete consente di monitorare, con periodicità mensile, le variazioni del campo di temperatura superficiale di aree a degassamento diffuso (fumarole) in zone che non sono soggette a monitoraggio continuo, aumentando pertanto spazialmente le informazioni termiche nell’area.
La Rete è attualmente così composta:
- Campi Flegrei: 5 aree di misura per complessivi 18 punti di osservazione
- Vesuvio: 3 aree di misura per complessivi 3 punti di osservazione
- Ischia: 9 punti di misura
I rilievi sono eseguiti mensilmente in condizioni di non irraggiamento solare (essenzialmente di notte), utilizzando una termocamera portatile FLIR T1020 ad alta risoluzione (1024 x 768 pixel). La termocoppia utilizzata è di tipo K, con errore strumentale di circa 0.1°C nell’intervallo -200÷1260 °C. Le misure ottenute con la termocamera sono confrontate, quando possibile, con quelle eseguite con termocoppia rigida.
In alcuni siti e quando le condizioni lo consentono, le misure di temperatura vengono rilevate anche con l’ausilio di un drone equipaggiato con una termocamera FLIR VUEPRO ad alta risoluzione (640 x 512 pixel) e precisione ±5 °C (Figura 9).

Monitoraggio Geochimico
La Rete di Monitoraggio Geochimico permette di analizzare le composizioni chimico-isotopiche dei fluidi fumarolici, al fine di stimare le condizioni termodinamiche dell’acquifero idrotermale. Integrata con le misure del processo di degassamento diffuso, essa fornisce informazioni fondamentali per comprendere l’evoluzione e la dinamica del sistema vulcanico.
La Rete di Monitoraggio Geochimico è attualmente così composta:
- Campi Flegrei: 6 stazioni multiparametriche (Figura 10) di cui 3 anche multigas, 3 stazioni multigas, circa 70 punti di misura per campagne periodiche nell’area Solfatara-Pisciarelli, 15 stazioni in pozzo per il monitoraggio multiparametrico in continuo della falda
- Vesuvio: 2 stazioni multiparametriche, 15 punti di misura per campagne periodiche in area craterica
- Ischia: 1 stazione e 4 punti di misura per campagne periodiche nell’area fumarolizzata di Mt. Cito. (N.B.: la sorveglianza geochimica dell’Isola d’Ischia è di competenza della Sezione INGV di Palermo)
Il monitoraggio geochimico dei Campi Flegrei viene effettuato mediante:
- campagne mensili di campionamento dei gas fumarolici emessi dalla Solfatara di Pozzuoli e dalla zona dei Pisciarelli, analisi della composizione chimica (H2O, CO2, H2S, H2, Ar, N2, CH4,He e CO) ed isotopica (40Ar/36Ar, δ15NN2, δ13CCO2; δ18OCO2, δ2HH2O, δ18OH2O)
- campagne mensili di misura del flusso di CO2 e della temperatura del suolo a 10 cm di profondità, in circa 60 punti fissi ubicati all’interno del cratere della Solfatara
- campagne mensili di misura dei flussi di CO2 e della temperatura dal suolo su 28 punti fissi nella zona dei Pisciarelli
- monitoraggio continuo del flusso di CO2 dal suolo, gradiente di temperatura nel suolo, temperatura fumarole, pressione differenziale, parametri meteorologici e misure multigas tramite le stazioni automatiche FLXOV8 (ubicata a Pisciarelli), FLXOV1 e FLXOV5 (ubicate nel cratere della Solfatara); monitoraggio del gradiente termico del suolo nel cratere della Solfatara (stazione GTS1)
- campagne estese di misura del flusso di CO2 dal suolo nell’area Solfatara – Pisciarelli su un’area di circa 1.45 km2 (circa 400 punti di misura)
- campagne semestrali di monitoraggio della falda freatica, consistenti nel campionamento, analisi e caratterizzazione geochimica delle acque in circa 15 siti
- monitoraggio continuo della temperatura, conducibilità elettrica e del livello delle acque della falda freatica, tramite la rete di stazioni installate in pozzi
- misure periodiche delle emissioni fluide sottomarine, con stima del flusso di gas ed energia associati, nella batimetrica 0-25m, delle aree con maggiori emissioni presenti nel Golfo di Pozzuoli
Il monitoraggio geochimico del Vesuvio viene effettuato mediante:
- campagne periodiche di campionamento dei gas fumarolici emessi dalla fumarola FC5 sita a fondo cratere del Vesuvio, analisi della composizione chimica (H2O, CO2, H2S, H2, Ar, N2, CH4, He) ed isotopica (40Ar/36Ar, δ15NN2, δ13CCO2; δ18OCO2, δ2HH2O, δ18OH2O)
- campagne periodiche di misura del flusso di CO2 e della temperatura del suolo a 10 cm di profondità, su una maglia di punti fissi in area di bordo cratere (area anemometro) del Vesuvio
- campagne periodiche di campionamento delle maggiori fumarole di bordo cratere e analisi della composizione chimica
- misura in continuo del flusso di CO2 dal suolo (ogni 2 ore), della temperatura della fumarola principale, del gradiente di temperatura del suolo, della pressione e della temperatura atmosferica (ogni 10 minuti) tramite le stazioni multiparametriche FLXOV6 installata in area bordo cratere (settore SW) e la stazione FLXOV7 installata in area di fondo cratere

Analisi e disponibilità dei dati
Per tipologia e numero di reti strumentali, i Campi Flegrei, il Vesuvio e Ischia sono tra i vulcani meglio monitorati al mondo.
Le Reti di Monitoraggio sono dotate di Laboratori per l’acquisizione, l’analisi e l’archiviazione dei dati su server ridondati. Tutti i parametri del monitoraggio possono essere soggetti a revisione per migliorare i risultati delle analisi, aggiornare le stime e di conseguenza la qualità e la precisione dei dati pubblicati.
L’analisi e l’interpretazione dei dati raccolti ha portato ad una corposa produzione scientifica su riviste internazionali e nazionali (Osservatorio Vesuviano – Pubblicazioni scientifiche) nonché alla redazione di Bollettini periodici e Relazioni Annuali di aggiornamento sullo stato dei vulcani destinati al Dipartimento della Protezione Civile e condivisi pubblicamente sul sito web dell’INGV-OV (Osservatorio Vesuviano – BOLLETTINI DI SORVEGLIANZA).
I risultati di molte attività di ricerca sono stati fondamentali per lo sviluppo delle Reti di Monitoraggio, confermando la stretta sinergia tra monitoraggio e ricerca, da sempre punto di riferimento nelle attività dell’INGV-OV.
Per rendere maggiormente fruibile la considerevole mole di informazioni continuamente pubblicate sul sito web dell’INGV-OV e sui canali social dell’INGV, sono state create pagine tematiche dedicate alle tre aree vulcaniche napoletane:
In queste pagine tematiche è possibile accedere alle seguenti informazioni inerenti alla specifica area vulcanica:
– Ultimo terremoto localizzato e relativi parametri
– Mappe di scuotimento dei terremoti di Md ≥ 3.0
– Stato Attuale con sintesi grafica e testuale dell’ultimo Bollettino Mensile
– Bollettini di Sorveglianza – Archivio dei Bollettini di Sorveglianza
– Segnali Sismici in tempo reale delle principali stazioni sismiche
– Localizzazioni Sismiche degli ultimi terremoti e archivio storico
– News Pubblicate nella sezione “In Primo Piano”, con informazioni e approfondimenti
– Storia Eruttiva con l’evoluzione vulcanologica del vulcano
– Reti di Monitoraggio con mappe e informazioni relative alle reti strumentali
I dati prodotti dalle Reti di Monitoraggio multiparametrico e le relative elaborazioni sono disponibili sui siti web istituzionali e sui Bollettini periodici di monitoraggio.
Per una corretta interpretazione dei dati registrati dalle Reti di Monitoraggio occorrono competenze specifiche ed esperienza, oltre alla disponibilità degli strumenti di elaborazione e calcolo sviluppati dall’INGV e in uso presso l’Osservatorio Vesuviano e le altre Sezioni dell’INGV in Italia (o presso altre Istituzioni scientifiche).
Le interpretazioni elaborate dall’INGV-Osservatorio Vesuviano costituiscono l’unico documento ufficiale e validato sui fenomeni in atto ai vulcani dell’area napoletana. L’INGV non è responsabile delle interpretazioni e valutazioni compiute da terzi dei dati pubblicati nei Bollettini periodici o disponibili online.
Si ricorda, infine, che l’INGV è l’ente pubblico di ricerca deputato alla sorveglianza sismica e vulcanica in Italia (D.Lgs. n. 381 del 29 settembre 1999), ed è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile (D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018), operando con il Dipartimento della Protezione Civile sulla base di un accordo formale che disciplina le modalità di collaborazione, la gestione delle banche dati, la preparazione delle attività tecnico-scientifiche in emergenza, nonché l’attività di formazione, comunicazione e divulgazione sui temi della pericolosità e rischio sismico, vulcanico e da maremoti.
Quanto riportato nel presente articolo rappresenta in sintesi il risultato dell’impegno decennale che il personale dell’INGV-Osservatorio Vesuviano ha dedicato e dedica alla creazione, implementazione e manutenzione delle Reti e dei Sistemi di Monitoraggio. La gestione delle Reti di Monitoraggio vulcanico rappresenta un impegno di straordinaria complessità, che richiede non solo rigore scientifico, ma anche dedizione costante, spirito di servizio e una continua innovazione tecnologica che considera le Reti come laboratori aperti al futuro. I contenuti riportati in questo articolo sono in buona parte tratti dai Bollettini periodici e dalle Relazioni Annuali dell’INGV-Osservatorio Vesuviano.