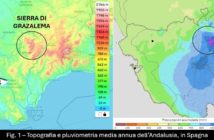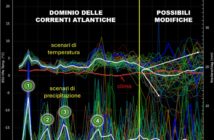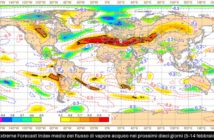Il clima è sempre cambiato, ma mai così in fretta
La rapidità con cui stanno aumentando le temperature è del tutto inedita negli ultimi milioni di anni e paragonabile alle principali crisi ecologiche globali del passato. La storia climatica della Terra è quindi a punto di svolta
di Massimo Sandal
www.lescienze.it

La Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2025, conosciuta anche come COP30, in corso a Belém, in Brasile, segna trent’anni di tentativi, da parte della comunità internazionale, di invertire la rotta della crisi climatica.
Nonostante termini come “antropocene” siano diventati ormai parte del lessico sia di scienziati che del grande pubblico (anche se non si tratta di una definizione geologica formale), politica e società faticano a comprendere l’entità del mutamento. Tanto che le emissioni di anidride carbonica nel 2025, secondo l’ultimo rapporto del Global Carbon Budget project, hanno toccato un nuovo record di 38,1 miliardi di tonnellate, con un incremento dell’1,1 per cento rispetto all’anno precedente. Uno dei ritornelli preferiti degli scettici del resto è “il clima è sempre cambiato”. La questione però è: come? E con quali conseguenze?
Negli ultimi anni gli scienziati hanno ottenuto un quadro relativamente accurato dell’evoluzione del clima sulla Terra lungo gli ultimi 540 milioni di anni circa – da quando sboccia la prima vita animale complessa, nel periodo Cambriano, a oggi. I modelli concordano sul fatto che la temperatura media del pianeta sia oscillata molto spesso, da un minimo intorno a 10 °C a un massimo superiore a 30 °C. Curiosamente, gli ultimi 40 milioni di anni sono un periodo freddo.
Ci troviamo infatti in uno dei rari intervalli climatici in cui esistono calotte polari di ghiaccio perenni. Per confronto in tutto il Mesozoico, l’epoca dei dinosauri, le temperature medie quasi mai sono scese sotto i 20 °C e spesso erano ben al di sopra, tanto che per lunghi intervalli il clima a entrambi i Poli era temperato. Secondo gli scenari peggiori calcolati dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) la temperatura media globale potrebbe raggiungere i 18 °C entro il 2100: un livello del tutto normale per la storia del nostro pianeta.
Ma il problema non è la destinazione. È come ci si arriva: quando un aereo tocca terra, fa tutta la differenza se si schianta o atterra dolcemente. Come si confronta allora l’attuale riscaldamento globale antropogenico con gli eventi di cambiamento climatico del passato?
Dal 1850 a oggi la temperatura globale media della Terra è salita di circa 0,06 °C ogni decennio; la temperatura degli oceani di circa la metà, 0,03 °C. Un ritmo che non ha paragoni di nessun tipo negli ultimi milioni di anni.
“Diversi indicatori, come per esempio gli isotopi stabili dell’ossigeno, ci permettono di ottenere informazioni relative alla paleotemperatura e alla dimensione delle calotte polari nel passato, spiega Davide Persico, docente di cambiamenti climatici globali e di paleobiologia all’Università degli studi di Parma. “Dagli studi che abbiamo fatto con altri colleghi in Antartide risulta che nei ghiacci antartici nel Quaternario sono registrate fino a 55 variazioni climatiche importanti tra glaciali e interglaciali.”
Ma gli eventi climatici avvenuti nel passato riguardano scale che vanno, di norma, dai 10.000 al milione di anni.
“Sono fenomeni legati soprattutto ai moti orbitali del nostro pianeta, mentre ciò che si manifesta oggi no”, prosegue Persico. “La quantità di anidride carbonica in atmosfera è passata da 280 a 420 parti per milione dalla fine del XIX secolo a oggi: si tratta di una variazione completamente fuori scala rispetto alla variabilità naturale che si è manifestata nell’ultima epoca geologica, il Quaternario.”
Lo conferma anche Barbara Stenni, docente di geochimica all’Università Ca’ Foscari di Venezia.
“Lo European Project for Ice Coring in Antarctica, ha prodotto una carota di ghiaccio a Dome C, una cima di oltre 3200 metri di altezza situata nel Plateau Antartico, da cui possiamo analizzare il contenuto passato dell’anidride carbonica in atmosfera”, spiega Stenni. “Sappiamo così che non era mai stato così elevato come ora negli ultimi 800.000 anni, un dato che è entrato a far parte anche dei modelli IPCC. E sicuramente la velocità del cambiamento non ha riscontro nelle ultime centinaia di migliaia d’anni.”
In sostanza, stiamo tornando bruscamente a livelli di CO2 che non si sono visti da milioni di anni. È vero però che ci sono stati altri eventi climatici veloci, nel recente passato, ma di tipo diverso da un cambiamento climatico globale. Un esempio classico è lo Younger Dryas, un intervallo di brusco raffreddamento dell’emisfero nord, iniziato 12.800 anni fa e concluso poco meno di mille anni dopo, in cui le temperature di regioni come la Groenlandia sono crollate anche di 10 °C nel giro di circa un secolo.
Non si tratta però di cambiamenti globali della temperatura (e quindi del bilancio energetico) del pianeta, bensì di riarrangiamenti del clima dovuti, con ogni probabilità, ad alterazioni della circolazione oceanica indotti dai più lenti cambiamenti globali.
“Lo Younger Dryas è stato un ritorno a condizioni fredde dell’emisfero boreale, molto probabilmente causato dal fatto che la calotta glaciale che copriva Nord America e Scandinavia stava cominciando a fondere”, chiarisce Stenni. “Questo processo di fusione ha portato a una modifica della circolazione delle acque profonde del Nord Atlantico, che ha portato a un raffreddamento dell’emisfero nord e un riscaldamento dell’emisfero sud.”
Eventi come lo Younger Dryas rappresentano semmai un esempio di come anche mutamenti graduali possano avere ripercussioni improvvise. Val la pena ricordare che anche oggi le regioni artiche sono tra le più sensibili al mutamento climatico: si stanno riscaldando a un ritmo quattro volte superiore rispetto al resto del globo. Inoltre, ci sono preoccupazioni per il destino attuale delle correnti dell’Oceano Atlantico.
Ciò non vuol dire che l’attuale riscaldamento globale sia un evento del tutto unico. Andando indietro nel tempo incontriamo uno shock climatico ancora più brutale: l’impatto dell’asteroide che estinse i dinosauri, 66 milioni di anni fa. Quel giorno, quando un corpo roccioso di dieci chilometri di diametro si schiantò nel Golfo del Messico, dove oggi c’è il villaggio di Chicxulub, il clima cambiò in un istante: le enormi quantità di polveri e ceneri sospese in atmosfera causarono un “inverno da impatto” pressoché immediato, con un repentino crollo di 10-15 °C nel giro di pochi anni.
L’evento climatico con cui però è più interessante confrontarci è il massimo termico alla fine del Permiano, 252 milioni di anni fa, quando la temperatura media della Terra superò in poco tempo i 30 °C. Allora come oggi si trattò di un evento di rapido riscaldamento globale indotto dall’immissione in atmosfera di enormi quantità di anidride carbonica.
“L’evento di riscaldamento più rapido conosciuto fu l’evento di caldo estremo attorno al confine tra Permiano e Triassico: la temperatura della superficie del mare nelle regioni tropicali aumentò di 8-10 °C nel giro di poche decine di migliaia di anni”, spiega Haijun Song, docente all’Università Cinese di Geoscienze di Wuhan, in Cina. “Il principale motore di questo rapido evento di riscaldamento furono le eruzioni vulcaniche su larga scala della provincia ignea siberiana e dei vulcani ad arco in altre regioni, alla fine del periodo Permiano, che rilasciarono una grande quantità di gas serra come l’anidride carbonica, mentre il magma si intruse in superficie e bruciò il carbonio organico sepolto negli strati, convertendolo in CO2, intensificando ulteriormente l’effetto serra.”
Un’ascesa assai rapida, geologicamente, ma ancora dalle 10 alle 100 volte più lenta dell’attuale. Le cose però potrebbero essere più complesse. Via via che ci si inoltra nel passato, la risoluzione dei dati paleoclimatici è sempre più sfuocata, e diventa difficile distinguere se un evento rapido di cambiamento del clima ha richiesto 10, 1000 o 10.000 anni. Uno studio del 2015 ha provato a stimare e correggere questa distorsione: secondo questi calcoli, il tasso effettivo di riscaldamento della superficie degli oceani alla fine del Permiano potrebbe avere raggiunto in alcuni intervalli i 0,4-0,5 °C al secolo, pari o addirittura leggermente superiore al ritmo odierno.

Se quindi non è necessariamente in assoluto un unicum, l’attuale riscaldamento globale è perlomeno del tutto paragonabile alle alterazioni climatiche più violente vissute dal pianeta negli ultimi 500 milioni di anni. Alterazioni che corrispondono sempre a estinzioni di massa su scala globale. Il riscaldamento globale di fine Permiano di cui abbiamo appena parlato corrisponde alla più vasta estinzione di massa mai registrata, con la perdita di oltre il 90 per cento delle specie marine e oltre il 70 per cento di quelle di terraferma.
Nel 2021 Haijun Song e colleghi hanno analizzato lo stretto rapporto tra mutamenti climatici e estinzioni biologiche. Ne deriva che le estinzioni di massa sono avvenute sempre in seguito a sbalzi di temperatura allo stesso tempo rapidi e intensi.
“Le principali cause sono l’incapacità degli organismi di adattarsi ai rapidi cambiamenti climatici e gli effetti ambientali sinergici causati dai cambiamenti climatici: secondo le nostre statistiche, le cinque principali estinzioni di massa avvenute durante il Fanerozoico furono accompagnate da rapidi cambiamenti climatici”, spiega ancora Song. “Tutte e cinque le grandi estinzioni di massa si verificarono nell’intervallo in cui l’entità della variazione di temperatura superò i 5,2 °C e il tasso di variazione di temperatura superò i dieci °C ogni milione di anni. Pertanto, guardando al passato, se la temperatura continua ad aumentare rapidamente, soprattutto se supera i 5-6 °C, questo potrebbe portare a un’estinzione di massa di specie.”
Anche sotto queste soglie però possono esserci ripercussioni. Se si escludono dall’analisi le cinque catastrofi principali, Song e colleghi hanno osservato che la correlazione tra il numero di estinzioni passate e il cambiamento climatico rimane, seppure attenuata; altri studi hanno confermato questa relazione.

Il clima dunque sì, è sempre cambiato. Ma i dati sono chiari: la rapidità con cui sta cambiando è del tutto inedita negli ultimi milioni di anni e paragonabile alle principali crisi ecologiche globali del passato. Ci troviamo dunque in un momento di svolta della storia climatica del pianeta ma stavolta possiamo frenare prima che sia troppo tardi. Chi non conosce la storia, si sa, è destinato a ripeterla; il passato della Terra ci avverte su quali conseguenze ci attendono se continuiamo a ignorarlo