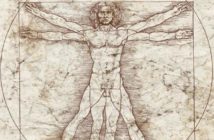L’eruzione laterale dell’Etna del 1950-51
di Stefano Branca e Mario Mattia
tratto da INGVVULCANI
Dopo le brevi eruzioni laterali del 1942, 1947 e 1949, avvenute senza impatto significativo sul territorio, il 1950 iniziò con la ripresa dell’attività esplosiva dal Cratere sommitale di Nord-Est (NE), che gradualmente aumentò durante il corso dell’anno per intensificarsi a partire dall’8 novembre.
L’eruzione vera e propria ebbe inizio “improvvisamente senza che vi fossero manifestazioni premonitrici” alle ore 22.00 del 25 novembre 1950, come riporta il professore Gustavo Cumin nella sua pubblicazione scientifica relativa all’evento, scritta dopo aver gestito, come vulcanologo dell’Università di Catania, l’emergenza legata proprio agli eventi eruttivi del 1950-51.
L’eruzione del 1950-51, per le sue caratteristiche vulcanologiche, rientra fra le eruzioni laterali dell’Etna di lunga durata (372 giorni) e contraddistinte da bassi tassi eruttivi medi (4,7 m3/s). All’epoca non esisteva una rete sismica sull’Etna ed erano presenti solo due stazioni localizzate, rispettivamente, a Catania presso i locali dell’Istituto di Vulcanologia dell’Università e ad Acireale presso l’osservatorio del Collegio Pennisi. Per questo motivo non era possibile localizzare gli eventi sismici e soprattutto registrare la sismicità di bassa magnitudo che interessava l’area sommitale del vulcano e si potevano acquisire solo le informazioni relative all’avvertibilità degli eventi maggiori da parte della popolazione. Questo, infatti, fu il caso delle due scosse sismiche verificatesi il 9 novembre, avvertite solamente in area sommitale e più precisamente presso la struttura del Grande Albergo dell’Etna, (localizzato a 1715 m di quota nel versante sud), che furono messe in relazione con l’aumento dell’attività esplosiva del Cratere di NE.
L’eruzione del 1950-51 ebbe luogo all’interno della desertica Valle del Bove, con la formazione di una fessura eruttiva, estesa per circa 1,5 km, lungo la parete occidentale della valle. In particolare, si formò un primo segmento della fessura fra quota 2850 e 2500 m, per poi ruotare verso ENE in basso. Un secondo segmento, orientato E-O e posto a quote più basse, fu interessato da attività esplosiva stromboliana generata da numerose bocche e da emissione di cenere la cui ricaduta interessò il versante orientale etneo. L’attività esplosiva prodotta da questa fessura eruttiva fu discontinua e di bassa intensità e si concluse il 17 gennaio del 1951.
L’emissione di lava dalla bocca effusiva principale fu invece molto intensa durante i primi giorni di eruzione. In particolare,la mattina del 26 novembre la colata lavica aveva già percorso circa 4,7 km, raggiungendo la località denominata Piano Bello ad una quota di circa 1250 m, dopo aver aggirato gli antichi coni di scorie di M. Lepre e M. Finocchino Superiore e il rilievo di M. Finocchino Inferiore, sovrapponendosi in parte ai campi lavici delle eruzioni del 1811-12 e del 1852-53 (Figure 1 e 2).


Nei giorni successivi il fronte lavico si divise in vari bracci che avanzavano sia all’interno di un solco di drenaggio, denominato Torrente o Fosso Fontanelle, che si sviluppava all’altezza di M. Fontane, sia nell’area di Piano Bello, minacciando, rispettivamente, i piccoli borghi di Fornazzo e di Milo (Figura 3). A partire dal 2 dicembre la colata lavica iniziò a svilupparsi anche verso sud, in direzione della Val Calanna e, a partire dal 4 dicembre, furono osservati da Cumin i primi fenomeni di sovrapposizione dei flussi lavici all’interno della Valle del Bove. Fra il 6 e il 7 dicembre iniziò lo sgombero degli abitati di Milo e Rinazzo perché i fronti lavici avanzavano minacciosi subito a monte delle due frazioni, ad una distanza di circa 1 km.

Durante questa fase drammatica per la popolazione etnea, il fronte lavico più avanzato raggiunse la quota di 765 m, sviluppandosi per oltre 8 km e interrompendo la strada tra Milo e Fornazzo in corrispondenza del Torrente o Fosso Cacocciola, nei pressi delle prime abitazioni di Rinazzo.
Durante il primo mese di eruzione, anche grazie al graduale sviluppo dei tunnel di scorrimento lavico all’interno della Valle del Bove, i fronti lavici furono ben alimentati, tantoché il 28 dicembre un nuovo flusso lavico si sviluppò nuovamente lungo il Fosso Fontanelle e coprì un’importante sorgente, sebbene di piccola portata, localizzata lungo l’incisione ad una quota di 1122 m. Questo flusso interruppe la strada tra Fornazzo e Linguaglossa nel tardo pomeriggio del 31 dicembre e il giorno seguente passò sotto il ponte della strada Fornazzo-S.Alfio, riversandosi all’interno dell’ampia valle denominata Cava Secca e formando una cascata di lava alta circa 40 metri. All’interno della cava la colata raggiunse la quota minima di 625 m e con una lunghezza massima di 9,7 km dalle bocche.
A partire dalla fine di gennaio il tasso effusivo alla bocca iniziò gradualmente a diminuire, segnando l’inizio di una seconda fase dell’eruzione che rimarrà limitata all’interno della Valle del Bove. Infatti, in questa seconda lunga fase, che durò poco più di dieci mesi, il flusso lavico alimentato dalla bocca effusiva di quota 2250 m scorreva all’interno dei tunnel, alimentando numerosi flussi che si sovrapponevano nella porzione centrale del campo lavico, i cui fronti più avanzati si arrestavano fra quota 1650 e 1550 m, raggiungendo quindi lunghezze massime di poco superiori ai 3 km. La notte tra l’1 e il 2 dicembre 1951 cessò l’emissione lavica alla bocca effusiva e si concluse così, dopo 372 giorni di intensa attività eruttiva, questa grande eruzione laterale in cui fu emesso un volume totale di lava di circa 151,4 milioni di m3 e che generò un tipico campo lavico di natura composita con un’area estesa approssimativamente 10,9 km2.
Come riporta Cumin, “malgrado la sua lunga durata ed il volume di lava emesso l’eruzione non causò al possesso fondiario danni assai forti e ciò per il fatto che gran parte delle colate laviche, estese per una superficie di 1032.1 ettari, si riversarono o su terreni sterili o su degli incolti produttivi. I terreni intensamente coltivati (castagneti, noccioleti, vigneti e frutteti) ricoperti dalla lava assommano in tutto a poco più di 53 ettari di superficie: sicché i danni alle colture ed alle poche e rudimentali costruzioni sono stati valutati tra gli ottanta e gli ottantacinque milioni di lire”.
Come per ogni grande evento eruttivo, anche questa eruzione fece registrare un elevatissimo numero di visitatori stimato da Cumin in una media giornaliera fra le 1000 e le 1500 persone per un numero complessivo di circa 150.000 mila persone riproponendo, durante questa vicenda, tutti quei riti che hanno radici antichissime. Questo alto numero di visitatori costituisce sicuramente un primo caso di “turismo di massa”, per un piccolo territorio di poche migliaia di abitanti, che anticiperà di oltre 50 anni quella che gradualmente, durante il XXI secolo, diventerà la problematica legata alla gestione della fruizione del vulcano durante gli eventi eruttivi.