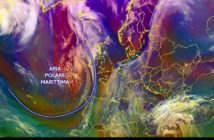I vulcani di fango dell’Etna: una finestra sul profondo e meraviglia naturalistica
di Salvatore Giammanco
ingvvulcani.wordpress.com
Spesso si associa al concetto di fango quello di una sostanza vile, fastidiosa, inutile in quanto sterile. In realtà, nell’ambito geologico il fango può indicare delle situazioni geologiche e geodinamiche estremamente interessanti e utili per comprendere i meccanismi reconditi di una attività vulcanica e tettonica. Nell’ambito naturalistico e paesaggistico, inoltre, il fango può creare forme ed ambienti di rara ed assoluta bellezza. Il fango non è presente sulla superficie soltanto laddove affiorano argille, ma può anche essere prodotto “ex-novo” a causa di fenomeni geologici (spesso definiti “pseudo-vulcanici”) legati alle dinamiche vivaci del nostro pianeta. In aree sismo-tettoniche attive e in bacini sedimentari geologicamente recenti l’eruzione più o meno violenta di fanghi dal terreno, spesso accompagnata da emissione di fluidi meno densi e iper-salini, indica zone di sovrappressione di fluidi accumulatisi nella crosta a profondità generalmente non superiori ai 10 km e rilasciati in superficie attraverso fratture e/o faglie attive. Per una conoscenza più approfondita dell’argomento si rimanda all’interessante articolo di Alessandra Sciarra e Tullio Ricci.
In Italia sono tante le aree con presenza di vulcani di fango, in prevalenza lungo le maggiori dorsali montuose o in alcune porzioni di piane alluvionali. Nell’area dell’Etna, il maggiore vulcano attivo d’Europa ed uno dei più attivi al mondo, esistono tre zone nelle quali si osserva da lunghissimo tempo (almeno 10.000 anni) l’emissione in superficie di fluidi ad alta salinità spesso ricchi in fango e sempre associati alla presenza di gas gorgoglianti in maniera vigorosa. Queste emissioni fluide prendono il nome di “Salinelle” (il nome chiaramente deriva dalla coltre biancastra di sale che si forma, soprattutto nel periodo estivo, attorno alle bocche eruttive) e sono ubicate nei dintorni dell’abitato di Paternò (CT), ai margini sud-occidentali dell’Etna.
Il più noto ed il più esteso dei tre siti è quello detto Salinelle di Paternò o dei Cappuccini (perché ubicato nei pressi della cosiddetta Collina dei Cappuccini dove era ubicato un vecchio convento di frati) o anche dello Stadio, in quanto nei suoi pressi è stato costruito lo stadio di calcio di Paternò (Figura 1 e video alla fine dell’articolo).

In questo sito le emissioni fluide sono costituite da gas che trasporta in superficie acque iper-saline che, frequentemente, ma non sempre, sono miste a fango e talora anche a idrocarburi pesanti (essenzialmente bitume). La peculiarità di tali acque è anche quella di avere una temperatura minima costante attorno ai 20-25 °C e quando vi sono attività eruttive più intense (veri e propri parossismi) la temperatura aumenta fino a sfiorare i 50 °C (Figura 2).

Il secondo sito è quello delle Salinelle del Fiume, ubicate qualche chilometro ad ovest di Paternò in vicinanza del fiume Simeto (da cui il nome). In questo sito l’attività è simile a quella delle salinelle dello Stadio, ma molto meno intensa. L’emissione di fango è molto rara e le quantità di gas ed acque salmastre emesse sono decisamente modeste e con temperature non differenti da quelle ambientali.
L’ultimo sito è quello delle Salinelle di San Biagio o del Vallone Salato, dette anche di Belpasso in quanto ricadono nel territorio comunale di questo paese pur essendo ubicate pochi chilometri ad est di Paternò. Le Salinelle di San Biagio sono caratterizzate da attività abbastanza differente dalle altre Salinelle; infatti, le emissioni fluide sono costituite quasi esclusivamente da fanghi ad alta densità, oltre che ai gas, e la loro temperatura è anche in questo caso prossima a quella dell’ambiente.